C’è una vertigine che si annida tra la cenere e l’inesistenza, una febbre lucida che consuma, un sole nero che anima un uomo ridicolo. Il maestro Fedor Dostoevskij elabora un sogno che non è solo un sogno: è un contagio metafisico, un’apocalisse di rinascita; una confessione allucinata, un inno delirante che vibra, una poesia infima.
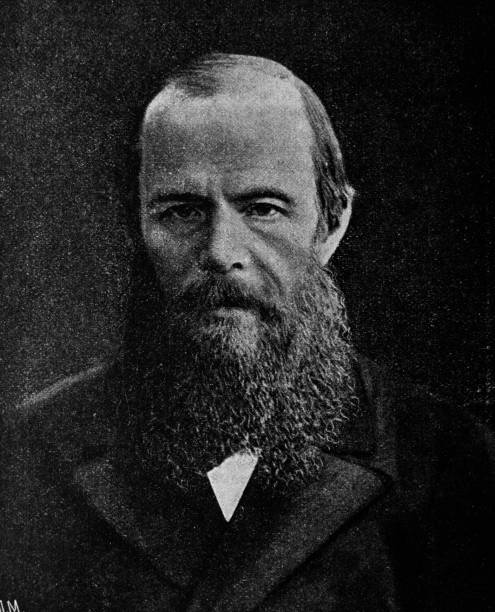
Il sogno di uomo ridicolo, racconto pubblicato nel 1877, è, purtroppo, un frammento poco conosciuto della letteratura di Dostoevskij. Spesso ci dimentichiamo della valanga di questo profeta, indubbiamente uno dei migliori che il mondo abbia mai potuto accogliere. Questo racconto si affianca ai suoi romanzi più celebri in termini di infinità di spirito, ma nella sua brevità, nella sua concretezza, porta nel cuore un buco, una marcescenza filosofica. Il protagonista è colui che sa, con la certezza mortale di chi ha troppo pensato, che nulla ha senso. Il mondo è indifferente. Le stelle lo ignorano. Le risa degli altri lo perforano come chiodi nel legno tenero. Eppure è nella risoluzione del suicidio — quella calma glaciale e oscura — che sboccia il miracolo: il sogno.
Un’invasione, un’estasi tumorale. Un altro pianeta, una Terra incontaminata, dove l’uomo è ancora innocente e i fiori parlano d’amore. Qui, Dostoevskij si fa profeta drogato d’assoluto, e l’uomo ridicolo diventa il nuovo Adamo, l’anti-Mefistofele che predica il bene con la voce da invasato.
Ma la grazia non dura. Egli è un virus, un seme guasto gettato nell’Eden, e porta con sè il neo che contraddistingue l’umanità intera: la corruzione. Il peccato si insinua non con l’odio, ma con la coscienza. La conoscenza del bene e del male come un veleno che spalanca gli occhi e li acceca. E quel mondo, quell’idillio visionario, si sgretola sotto le sue mani colpevoli. E torna il buio.
"Io sono ridicolo. Adesso mi hanno detto che sono pazzo. Questo sarebbe un progresso, se non fosse ancora per me tanto ridicolo come era prima."

Ma ecco l’epifania: l’amore salva. L’amore assoluto, folle, grottesco. L’amore per tutti e per il prossimo. L’amore ridicolo come lui. L’uomo si sveglia, e il sogno resta dentro come una brace. Ha visto la verità — o l’ha inventata? Che importa. Lui ora ci crede. E questo gli basta.
"Che importa se tutto è una menzogna, se io ho visto la verità, se l’ho vista e so che è la verità?"
Bisogna incendiare; il suo grido è dolce e rabbioso, un indemoniato che ha visto il sacro. L’uomo ridicolo è ora l’uomo febbrile, infettato dalla fede, non per forza intesa teologicamente; fede nel prossimo, nella speranza, nell’esistenza umana. Dostoevskij non ci dice se sia pazzo o santo. Non ci consola. Ci lascia in quella febbre — lucida, visionaria, poetica — dove tutto brucia, e tutto pare reale.
L’uomo ridicolo rappresenta il soggetto moderno alienato: disilluso, consapevole dell’insensatezza della realtà, incapace di trovare un fondamento oggettivo al valore. Questo è il cuore pulsante: non il rifiuto del bene, ma l’impossibilità di crederci. La sua decisione di suicidarsi è un gesto radicalmente filosofico, non psicologico: è la coerenza logica di chi non vede più alcuna necessità di esistenza.
"La vita è paradiso, e noi tutti siamo in paradiso, ma non vogliamo capirlo."
Allo stesso tempo il sogno non è un’evasione, ma un’interruzione dell’assurdo. È la possibilità che l’assoluto esista, nonostante tutto. In esso, l’uomo entra in un mondo “perfetto”, non guastato dalla menzogna dell’uomo, dove gli esseri umani vivono in armonia perché non conoscono la separazione tra sé e l’altro. È un'utopia morale che Dostoevskij non propone come realizzabile, ma come rivelazione interiore. Il sogno funziona come un mito platonico: non è vero in senso empirico, ma in senso essenziale.
Il paradiso onirico si corrompe quando l’uomo introduce il concetto di verità soggettiva. Con ciò, Dostoevskij riprende il suo tema ossessivo: la libertà come doppio taglio. Senza libertà, non c'è male, ma non c’è nemmeno amore. Con la libertà, nasce la possibilità del peccato, del male, ma anche del sacrificio, della grazia. La caduta non è casuale: è la conseguenza necessaria della coscienza morale.
Alla fine, il protagonista non si suicida. Non perché abbia trovato una prova razionale della bontà del mondo, ma perché ha visto una verità che non si può spiegare, solo testimoniare. Come in Kierkegaard, Camus, Beckett o Ionescu, l’assurdo non si risolve: si attraversa. Ma a differenza di questi, Dostoevskij non si ferma all’assurdo: vi innesta una fede che è atto folle, gratuito, ridicolo persino — e proprio per questo profondamente umano.
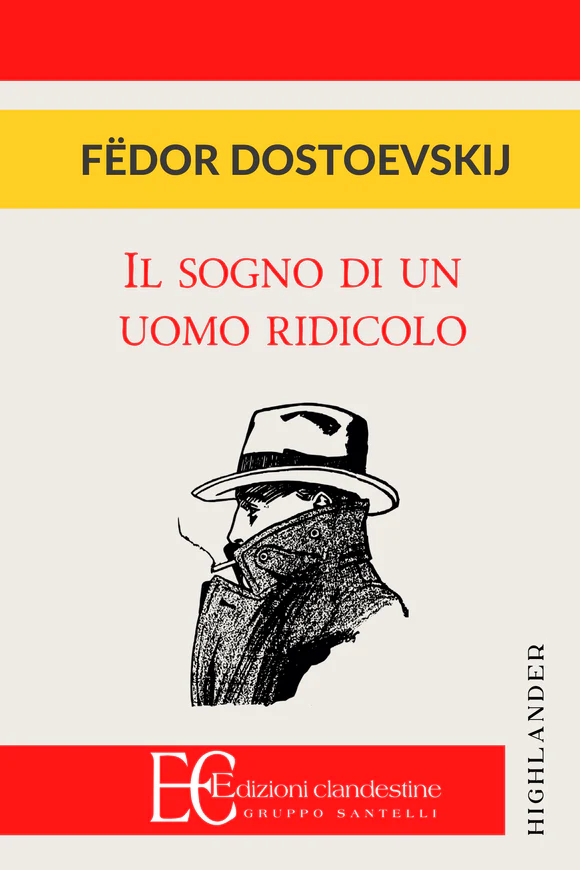
"Io ho visto la verità, non dico che l’ho sognata, l’ho vista."
L’uomo ridicolo è in definitiva l’eroe tragico dell’età moderna. Non trionfa sul male, ma sceglie di amare nonostante tutto. Non ha risposte, ma ha una missione: bruciare il mondo. È un profeta dell’impossibile, un santo senza tempio, un uomo che, toccato dal nulla, decide di opporgli l’infinito.
Dostoevskij, come sempre, è un ago ipodermico pregno di estasi: cosa succede quando l’uomo, svuotato di senso, si lascia possedere da una visione? Cosa resta del sogno quando ci si sveglia? Forse solo cenere. Ma persino la cenere può incendiare il mondo.
